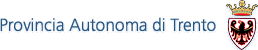Provincia Autonoma di Trento - Minoranze Linguistiche
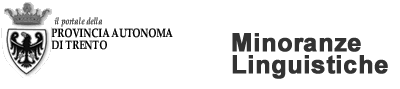

Forum nazionale per le Minoranze Linguistiche (4)
Presentata la ricerca sulla percezione delle minoranze in Trentino
Nella sessione di apertura del Forum è stata presentato il volume "I sentieri dell'Identità, Cimbri Ladini, Mòcheni visti dai Trentini", contenente i risultati di un'indagine sulla percezione delle minoranze linguistiche da parte della popolazione trentina (autore il prof. Salvatore Abbruzzese dell'Università di Trento, ha collaborato la dott.ssa Sabrina Girardi) di cui pubblichiamo l'introduzione e una sintesi dei risultati:
"Chiedersi come siano percepite le minoranze è tanto più importante quanto più ci si riproponga di evitare gli stereotipi ed i luoghi comuni, ma per farlo occorre chiedersi cosa ci sia dietro quest’ultimi. Proprio per questo il primo nucleo del questionario ruota intorno alla vera domanda di sfondo che può riassumersi con il “cosa si sa delle minoranze in Trentino”. Se ne conosce almeno il nome? I luoghi geografici dove queste risiedono? L’ampiezza demografica di ciascuna di esse? Gli altri sono sempre la vittima principale degli stereotipi. Positivi o negativi che siano, non c’è nessun altro campo dove gli stereotipi siano altrettanto in agguato come nel caso in cui si parla degli altri, cioè di tutte le realtà umane e sociali che non sono riducibili a noi, ma devono esser comprese nella loro alterità. Gli altri hanno la duplice di essere eterni semi–sconosciuti. O almeno sono conosciuti quel tanto che basta per scoprire la loro diversità, ma sempre troppo poco per poter vantare un minimo di conoscenza reale. Dall’analisi delle interviste emerge un secondo elemento di riflessione, per molti versi inatteso. Si tratta del genuino riconoscimento del limite conoscitivo. La maggior parte degli intervistati infatti, anche di fronte alle asserzioni maggiormente provocatorie, preferiscono ammettere di non sapere piuttosto che controfirmare giudizi interlocutori. Si preferisce, in altri termini, ammettere di non conoscere nulla o quasi nulla delle minoranze, piuttosto che avvalorare giudizi schematici e rinforzare gli stereotipi del senso comune. Certamente non mancano le normali frizioni dovute alla continuità geografica o alla convivenza comprensoriale, ma ciò non altera il dato globale che si riassume nel riconoscimento del proprio non sapere e, proprio per questo, apre le porte alla possibilità ed alla necessità implicita del comprendere. Si rivelano allora necessarie e non più rinviabili alcune considerazioni di fondo che vale la pena qui ripresentare. La categoria della visibilità, per quanto legittima, sia nel desiderio che la anima sia negli obiettivi che persegue, sembra essere oramai non più sufficiente per assicurare una conoscenza diffusa sulle minoranze. Ciò sembra essere dovuto in primo luogo al carattere estremamente mediatico di tutta la comunicazione contemporanea: in una società fondata sull’estensione dei processi comunicativi e sulla loro capacità invasiva è abbastanza difficoltoso per le minoranze poter riuscire a penetrare la sensibilità di una audience già costantemente raggiunta da messaggi e sollecitazioni di ogni tipo. Sembra essere assolutamente necessario far sì che l’insieme dei processi comunicativi si basi su qualcosa di supplementare rispetto alla semplice dichiarazione d’esistenza. Se per oltre due decenni l’obiettivo perseguito dalle minoranze è stato quello della visibilità, oramai si può aggiungere che accanto a questo deve essere necessariamente affiancato quello della conoscenza. Non basta che le minoranze siano visibili, occorre che siano conosciute. Dalla presa d’atto di una presenza è necessario passare alla comprensione di una cultura.
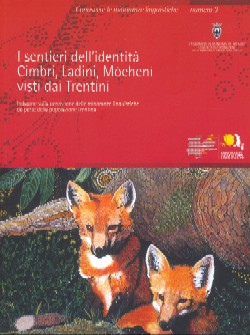
Per produzione delle letture degli avvenimenti si fa qui riferimento a concreti eventi storici che le minoranze hanno vissuto (si pensi alla prima ed alla seconda guerra mondiale, o al regime delle opzioni). Questi eventi vissuti dalle comunità delle minoranze non solo costituiscono un tassello fondamentale della storia del Trentino, ma sono anche un vero e proprio ponte attraverso il quale cultura trentina e culture mòchena, cimbra e ladina possono comunicare e trovare quei vicendevoli riscontri che sono il primo anello di un processo di comprensione culturale che non sfocia sull’omologazione ma sulla specificità. Gli eventi fanno la storia, ma incidono anche sull’elaborazione della memoria sociale. Comprendere le minoranze vuole allora dire, in primo luogo, conoscere la storia che le ha costituite come tali, gli eventi che l’hanno scossa e le soluzioni che l’hanno caratterizzata. Affinché questo si realizzi è tuttavia necessario oltrepassare anche una concezione riduttiva della cultura stessa in virtù della quale quest’ultima non si ridurrebbe che ad una serie di costumi, feste e saperi pratici. Occorre a questo punto individuare e distinguere i due livelli possibili di ogni costruzione culturale: quello descrittivo e quello analitico. Sul piano descrittivo la cultura esprime una lettura della realtà che non può che essere osservata nella sua alterità. L’aspetto linguistico rientra in questa dimensione. Lingua e toponomastica rinviano entrambe ad una presenza culturale che si rende immediatamente visibile.
Sul piano analitico la cultura delle minoranze è tuttavia anche e soprattutto una produzione spaziale e temporale con una sua logica propria. Ladini, Mòcheni e Cimbri hanno prodotto delle letture condivise degli avvenimenti e delle interpretazioni ragionevoli dei luoghi. Fino a quando non si accede a questa sfera culturalmente produttiva le loro culture restano autoreferenziali e sostanzialmente incomprese. Questo processo fondamentale di riconoscimento è il principio cardine di qualsiasi approccio ad una cultura altra che ne avvia la comprensione e consente l’acquisizione di un sapere minimo ma reale, proprio perché fondato su eventi condivisi o comunque potenzialmente comprensibili. Per produzione di letture ragionevoli dei luoghi si intende quel secondo ambito di lavoro proprio di tutte le culture e riassumibile nella “costruzione sociale del territorio”. Ogni cultura non si limita infatti solo a “rappresentare” la realtà, ma essa si appropria anche dei luoghi instaurando una gerarchia. Sacro e profano, scambi e commerci, istituzioni e autorità, festa e relazioni di comunità costituiscono altrettanti ambiti dell’agire sociale che si sono per lungo tempo affermati in luoghi specifici: magari gli stessi di oggi, ma iscritti in una gerarchia completamente diversa, dove i poli di riferimento politici e culturali erano magari situati altrove rispetto a quelli contemporanei.
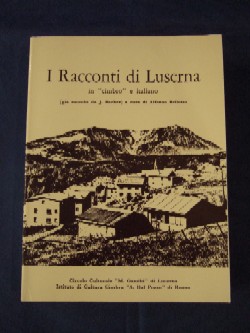
Tutte le culture “lavorano” il territorio esattamente come hanno “lavorato” i fatti storici che le hanno segnate. Questi luoghi antropologici sono oggetto di memoria storica, ma anche di relazione e soprattutto di relazione identitaria: sono cioè i luoghi che contano per una comunità. Se comprendere la lingua degli altri può essere un risultato raggiungibile solo alla fine di un lungo percorso di studio, non così è per la memoria storica e per i luoghi identitari. Tanto la prima quanto i secondi costituiscono un vero e proprio alfabeto universale delle culture in base al quale queste possono essere conosciute e comprese. Diviene allora fondamentale andare oltre la semplice visibilità per fornire informazioni sulla memoria storica, intendendo con tale termine non solo l’insieme dei fatti che hanno attraversato e scosso le singole comunità. Ma soprattutto come questi fatti stessi siano stati valorizzati e resi significativi all’interno della memoria collettiva. Altrettanto diviene importante ricostruire la geografia dei luoghi che contano per la singola minoranza, spiegandone le ragioni, cioè i fatti, che hanno contribuito ad individuarli ed a trasmetterne la funzione relazionale ed identitaria da una generazione all’altra.
Per le minoranze linguistiche, la possibilità di essere comprese diviene tanto più probabile, quanto più si affermano questi due ambiti dell’esperienza sociale condivisa. Tali aspetti possono funzionare come ponti di confronto e di dialogo. Detto ancora in altri e più chiari termini se la visibilità non fa che reiterare una differenza, solo la percezione di una condivisione può costruire quel terreno di fondo in base al quale il dialogo è possibile e la differenza non è solo una reiterata presentazione delle specificità, ma diviene il metro di misura con il quale è stata vissuta la stessa storia e sono stati costruiti e dotati di senso gli stessi luoghi. Solo a queste due condizioni la percezione delle minoranze può dare vita ad una comprensione durevole e lasciar esprimere tutte quelle potenzialità che, ancora oggi, sembrano restare in ombra."
- SINTESI DEI RISULTATI DELLA RICERCA (73kb - PDF)